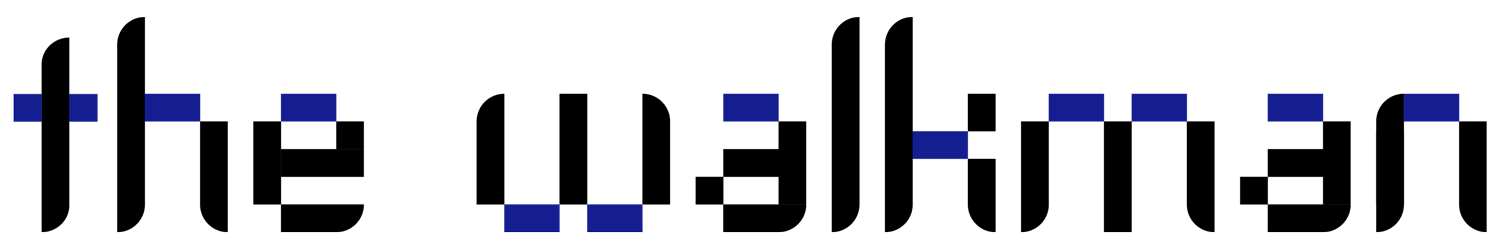L’ amore per il teatro, sensibilità e perseveranza: Carlo Giuseppe Gabardini non è solo un comico italiano, ma molto di più. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo personalmente e di scoprire come dietro alla figura goffa e divertente di Olmo Ghesizzi, si nasconda una realtà fatta di gavetta e preparazione, una storia di teatro e di vita quotidiana, di delusioni e di soddisfazioni, di riflessioni e impegno sociale.
Come ti sei approcciato al mondo della tv, del teatro e del cinema? Qual è stato il tuo percorso formativo?
Tutto iniziò quando avevo quattordici anni, presso Quelli Di Grock, scuola di teatro a Milano.
Ero al liceo con il mio migliore amico e ricordo che dissi “quando mento, le persone mi credono e questa cosa mi piace moltissimo, quindi forse dovrei fare l’attore.”
Siamo andati a fare il corso insieme, eravamo i più giovani perché avevamo entrambi quattordici anni ed era un corso aperto a tutti, non solo ai ragazzi.
Ricordo ad esempio che c’era un assicuratore al quale interessava solo migliorare la dizione.
Mi fa ridere perché Beniamino, il migliore amico di cui ti parlavo è colui con cui poi ho fondato Aprile, l’associazione poi è diventata Esterni che ha anche fondato il Milano Film Festival.
Finito il liceo, feci il mio coming out più difficile, dire a mio padre che non avrei fatto l’avvocato, ma l’attore!
Feci un provino alla Paolo Grasso, scuola civica di arte drammatica di Milano, e fui preso, mentre a Roma, presso l’accademia, ricordo che mi guardarono malissimo, forse perché dovetti cantare una canzone, non canto affatto bene!
Anche a Milano cantai una canzone, Voglia di libertà di Pierangelo Bertoli, me lo ricorderò tutta la vita.
Alla fine quindi, feci la Paolo Grassi, vicino casa, vivevo con mamma fino a l’altro ieri (ride). Tuttavia fu una bellissima esperienza, la mia casa era sempre piena di amici provenienti da tutti Italia.
Durante l’accademia civica quali sono state le prime esperienze che hai fatto, la gavetta?
La prima vera esperienza che ho fatto è stata la bocciatura. (ride) Dopo due anni di Paolo Grassi mi hanno bocciato come attore. Solitamente quando sei bocciato alla Paolo Grassi non puoi ripetere, hai finito.
Trovo sbagliato e disumano che gli insegnanti prendano la decisione dopo due anni, perché a quel punto la vita di un aspirante attore diventa molto complicata.
Mi chiesero comunque di rimanere come drammaturgo, in quanto avevo presentato dei miei elaborati al corso di drammaturgia, anche se non mi interessava frequentare una scuola per imparare a scrivere, credo si possano insegnare solo le basi, le tecniche. Comunque il lato positivo della Paolo Grassi è che non impone un’impronta univoca, ma permette l’incontro con insegnanti che lavorano, con attori, sceneggiatori, i quali hanno dei progetti e insegnano in base al proprio mestiere.
Per me è stato fondamentale l’incontro con Gabriele Vacis, uno di quelli che mi bocciò, ma che poi mi chiese di fare l’attore nelle sue produzioni e anche quello con Giampiero Solari. Solari mi disse “A. non ti avrei mai bocciato B. tu mi piaci tantissimo C. tu questo spettacolo lo fai di sicuro”, e mi fece recitare.
Successivamente lavorammo con Marco Paolini e con lui feci entrambe le cose, aiutando i miei compagni attori a scrivere racconti biografici. Paolini mi chiese anche di riscrivere ‘Vajont’.
Che cos’ è per te la gavetta? E’ importante? Te lo chiedo perché è una mia fissazione.
Secondo me è fondamentale. Il problema è capire cosa sia effettivamente la gavetta, perché in ogni campo è a sé.
Penso sia indispensabile, ma c’è sempre un grado di fortuna e di capacità di adattamento al tipo di gavetta che s’incontra; poi ci sono le finte gavette, dove ti schiacciano e ti fanno fare il giovane attore fino a quarantanove anni, di solito il primo attore ne ha ottantasei.
La gavetta per me è stato Paolo Rossi. Mi disse: “Cercavo te, voglio che tu faccia uno spettacolo con me, come attore”. Presi parte a Romeo and Juliet, spettacolo che ha fatto più di 300 repliche. Io recitavo nei panni finto spettatore che, in piedi davanti alla cassa disturbava dicendo: “Ma come non c’è il mio biglietto, siamo in due, non è possibile?!” con questo simpatico accento milanese.
Recitare a Milano non fu difficile, ma a Napoli, Salerno, Lecce e Roma la reazione del pubblico era sicuramente più accesa, soprattutto quando toccavo temi come quello del lavoro. Una mia battuta era: “Io non capisco questo problema del trovare lavoro perché io l’ho trovato subito, sono di Saronno”, puoi immaginare l’odio del pubblico.
Una volta in radio un ascoltatore mi disse “ciao io voglio parlare con Carlo Gabardini e voglio dirgli di avergli salvato la vita”, Mi raccontò che era presente a una replica del mio spettacolo, dicendo che il suo vicino di posto si alzò e disse, riferendosi a me “io adesso vado e lo ammazzo questo di Saronno” e lui lo fermò dicendogli di stare tranquillo perché ero un attore.
Questo fu l’inizio della mia gavetta, sia per il ritmo sostenuto, Paolo è uno che va in tournée e fa duecento date l’anno, sia per le occasioni che si presentarono, come quando gli consegnai novanta pagine di materiale per dei monologhi che avrebbero rinnovato i testi del suo repertorio. Iniziai così a scrivere per Paolo Rossi, il primo spettacolo fu Questa sera si recita Moliere, nel quale recitammo entrambi. In seguito scrissi “Il signor Rossi e la costituzione”, un monologo. Ricordo che eravamo a Correggio e debuttammo li. Durante le prove mi chiamarono per fare il provino di Camera cafè, per offrirmi la parte di Silvano, il personaggio “sfigato”. A contenderci il ruolo rimanemmo solo in due, io e Alessandro Sanpaoli. Erano molto indecisi su chi scegliere, anche per l’importanza del ruolo, che dopo quelli di Luca e Paolo, era considerato il principale.
Ricordo che io candidamente dissi: “Guardate se dovessi scegliere io, prenderei Alessandro a fare questo ruolo non me, perché Silvano è un personaggio mammone, ma è un bel ragazzo, il percepito del pubblico è che questa figura non abbia relazioni con donne perché vessato dalla mamma. Se il pubblico vedesse un ciccione che non va a letto con donne, penserebbe semplicemente che la motivazione sia che è brutto e il personaggio verrebbe spostato”.
Presero lui, infatti, e mi ringraziarono molto per il consiglio. Io andai a casa. La settimana dopo, mi chiesero se volessi andare a scrivere Camera cafè, per fare lo sceneggiatore. Dissi di sì. E non è un caso che sia così, io vengo dal teatro e non avevo intenzione di scrivere per la televisione, ma Camera cafè è veramente il programma più teatrale che sia esistito in televisione.
E’ una quarta parete, un insieme di piani sequenza, come nel live, non ci sono interruzioni e se si sbaglia, si deve ricominciare dall’inizio. Si percepisce la tensione da palco, perché si recita tutta la scena senza pause, senza pick-up montati a piacimento.
La costruzione è drammaturgica, un meccanismo quasi da Vaudeville. Un grande corridoio con delle porte, d’entrata e d’uscita. Attori che entrano ed escono dicendo le proprie battute, continuamente. Poi c’è l’ascensore, un’altra porta alla Vaudeville, direi una Vaudeville ante litteram perché inizialmente non c’era e invece è la cosa più teatrale che ci sia.
Tra i tuoi lavori ce n’è un altro molto importante. In quanto tempo avete ideato e realizzato Milano film Festival e cos’è?
Se si parte dal ’95 a oggi, abbiamo impiegato diciannove anni.
Fu un progetto che partì con una dose d’incoscienza e di un’altra cosa che ho incontrato altre volte nel corso della vita, una sorta di diffidenza. Volevamo fare un concorso perché ci sembrava impossibile che a Milano non ci fosse un concorso di cinema. A Milano mancava questa opportunità.
Ci dissero “un festival non può partire cosi dal basso, si deve iniziare a volerlo fare, trovare sponsor, trovare le istituzioni e partire in un altro modo”. Noi invece lo facemmo, la vera differenza, se vogliamo, è proprio questa. Aspetto, questo, che ci allontana anche dal festival di Roma, l’esatto contrario di Milano. Quando si incontrano persone che ti dicono “ma non è cosi che si fa” bisogna fregarsene e non farsi spaventare. Bisogna essere convinti e dirsi “io so fare così e così lo faccio”.
Semplicemente lo facemmo.
Il primo Milano film festival durò un giorno, nel centro territoriale comunale vicino al Piccolo teatro. Su trentotto film, ne mostrammo sei e ne premiammo uno. Il tema era Milano, ovviamente, e scrivemmo fuori la porta ‘tutto esaurito’ perché la sala che ci ospitava aveva una capienza di 100 persone e noi eravamo 340. Scrivemmo il cartello perché avevamo paura che arrivassero i vigili.
Il secondo anno il festival durò due giorni, il terzo, fino al decimo anno nel quale durò dieci giorni e oggi facciamo comunemente tra i dieci e i dodici giorni di festival al Piccolo teatro.
Te lo saresti mai aspettato?
Assolutamente no, assolutamente no. Nacque così, con noi che mettemmo 500.000 mila lire a testa.
Poi l’ufficio giovane del comune di Milano, già il secondo anno fornì un contributo di cui noi fummo felicissimi. Stiamo parlando di lire, circa cinque milioni, 2.500 euro di adesso con cui noi facemmo il Festival, ovviamente.
Una cosa che tengo a sottolineare è che è vero che del festival me ne sono occupato molto, ma adesso sostanzialmente sono i miei soci che lo seguono. Io faccio ancora parte della giuria, ma ci sono altri due direttori e collaboratori che lavorano sodo tutto l’anno. Il merito va a loro.
Un altro aspetto, a mio avviso unico, del Milano Film festival è stato la voglia di rilanciare. Se avevamo a disposizione 20mila euro di contributo, ne spendevamo 28mila. Abbiamo considerato e consideriamo tuttora ogni festival come un investimento sulla successiva edizione. Questo approccio è sicuramente positivo, perché è l’unico modo di far crescere un’iniziativa che parte dal basso. Ogni anno aggiungere un giorno significa persone pagate in più, stagisti, proiezioni, SIAE, diritti, soldi.
Sicuramente non mancavano i forse e le paure, come quella di non riuscire a riempire la sala da mille posti del Piccolo Teatro. Ci sono i pro e i contro, come in tutte le cose, però questo è l’unico modo possibile se l’interesse è di fare un bel festival e non quello di trovare un posto di lavoro. E’ questa la differenza.
Arriviamo al 31 ottobre 2012, faccio un bel salto, ma prima di arrivare al trentuno, quando hai capito di essere gay e come hai metabolizzato la cosa?
CARO ragazzo gay, o bisex, o indeciso o boh, la vita è durissima, spesso è uno schifo, ma la propria identità sessuale non può mai essere un motivo per deprimersi, farsi del male, uccidersi. Scusami se ti scrivo, ma io ho bisogno di dirti una cosa: essere gay è bellissimo. Non è una colpa, non è un atteggiamento che uno sceglie, è normale tanto quanto non esserlo.
Leggi qui la lettera integrale!
L’ho capito, l’ho sempre saputo.
Non ho un momento preciso, un episodio chiave, torno indietro nella mia vita e penso di averlo assolutamente sempre saputo.
Ovviamente ci sono dei momenti, come quando ti accorgi che ti piace il tuo compagno di banco.
Mi sono piaciute sempre anche le donne e probabilmente questo fatto, difficile da gestire perché per molti gay dire “mi piacciono anche le donne” è un’arma di difesa, ha fatto si che io non parlassi mai della questione dell’omosessualità.
Non che la negassi, perché sono stato fidanzato con un ragazzo quasi tre anni e sicuramente non parlavo di lui al femminile, anzi, però non rendevo pubblica questa situazione. Molti miei amici lo sapevano e molti no.
Una cosa di cui sono molto contento è la lettera.
Una lettera che riguarda l’omofobia, il non viversi bene la propria identità sessuale, un appello a fortificarsi in quanto gay e soprattutto a capire che essere gay è bellissimo. Questo è il vero cuore della lettera e credo che sia anche il motivo per cui ha avuto un tal eco. Ci sono moltissime persone che fanno coming out, però ho sempre la sensazione che anche i non omofobi, quelli che si dichiarano non omofobi, ti guardino come per dire “non sarai mai felice, non sarai mai felice come tuo fratello che è etero, non avrai mai una vita piena, mi spiace, ti voglio bene e ti accetto, puoi fare quello che vuoi, però purtroppo avrai una vita a metà”.
Credo che questo sia il vero problema, perché se si è circondati di persone che continuamente ti passano sottopelle questo messaggio “della vita a metà” si pensa che quella sia la verità e si perde il senso del proprio essere.
In realtà ci si ritrova una situazione in cui, cito un esempio della lettera, io sono dell’Inter e l’altro è della Juventus. Se lo juventino mi dicesse “interista di merda” io non ragionerei mai sul fatto che tifare inter sia sbagliato, sul fatto che tifare inter sia una cosa da depravati, anzi, io saprei benissimo che quelle parole derivino dal fatto che chi mi ha detto quelle cose, è juventino.
E poi, nelle ultime tre righe di questa lettera, c’è anche il mio coming out in cui scrivo: “Ho sempre pensato che la mia omosessualità fosse una non notizia, però se questa non notizia, nel momento in cui è detta, può aiutare qualcuno a decidere di non uccidersi, allora lo dico, io sono gay”.
E devo ammettere che non ero conscio del bene che potesse fare il coming out, invece devo ammettere che è molto importante dirlo, cambia tanto farlo in pubblico. Ti da energia.
Fare coming out significa uscire, dichiarare al mondo quello si è, non è un’azione esclusivamente legata agli omosessuali. Una persona che improvvisamente dice: “No, ho sbagliato università, non volevo studiare medicina, ma voglio fare legge, economia, sport” fa coming out e questa è un’occasione. Non abbiamo tante opportunità nella vita, bisogna cogliere questa occasione, su qualunque fronte essa sia, avere la forza di dire “io ho sempre sognato questo, il mio desiderio è questo, io penso di essere al mondo per questo” quindi a me interessa quel preciso istante e il momento sulla “gaytudine” ha la stessa potenza.
Tu vivi attivamente la comunità gay di Milano oppure hai continuato sempre la tua vita normale senza partecipare alle attività ?
C.G. Parli di militanza?
N.P. No, non solo!
C.G. Di locali?
N.P. Si esatto.
Frequento i locali gay da tanti anni, da molto tempo prima della lettera, e mi piacciono moltissimo. Questo per dire ancora una volta che non è che tenessi particolarmente nascosto il mio essere gay, anche perché quando andavo in quei locali, dicevano sempre “Olmo è gay, Olmo è gay” quindi non è che mi nascondessi in un angolino al buio, nel mondo gay lo sapevano tutti.
Poi come ben sai, nel mondo gay le voci sono rapidissime.
Vorrei scrivere sui locali gay, ci sono aspetti che mi incuriosiscono moltissimo. In realtà va compreso che i locali hanno un’importanza fondamentale nel mondo delle tematiche LGBT, ma a mio parere sono luoghi importanti perché hanno fatto sì che un ragazzo potesse chiedere a un altro “balli con me?”, cosa che non può avvenire in un locale etero; avere la possibilità di scambiarsi della tenerezza in un luogo dove anche gli altri intendono scambiarsi della tenerezza.
Consigli a chi vuole diventare attore?
Di farlo. (ride)
E’ difficile. Forse mi sento un po’ fuori dal mondo scolastico, quindi non saprei consigliare una scuola, ma va capito cosa vuol dire fare l’attore.
La prima cosa che voglio dire è che fare l’attore è un lavoro quindi di uscire da quest’ottica, sbagliata che la società cerca di venderci. Non è solo una situazione riguardante la figura dell’attore, è una questione su tutto, perché cercano in continuazione di convincerci che sono il caso e la fortuna che portano al successo e questo secondo me è molto “reality”, no?
Siamo portati a pensare che solo incontrando la persona giusta al posto giusto si farà strada, ma non è cosi.
E’ vero, la fortuna è scandalosamente presente, non sto dicendo di no, però nel momento in cui capita, si deve essere pronti, sennò non si farà l’attore, ma il pupazzo. Quindi secondo me la cosa fondamentale è uscire da quest’ottica per cui “non dipende da noi” ma dal “fattore x”. Conta chi sei e la tua preparazione. La preparazione è fondamentale, devi prepararti a far l’attore.
Ci sono molte strade, non so se l’unica sia la scuola, certo se si vuole fare teatro, mi sembra un buon inizio, in alternativa si può cominciare a fare degli spettacoli e cercare delle regie, insomma, di modi ce ne possono essere tanti, è importante buttarsi sulla scena.
Ci sono secondo me diversi modi, non credo ce ne sia uno giusto. La parola “attore” è una parola “vasta”. Attore è come dire commerciante, dipende da cosa, dove e come lo vuoi fare.
Ci sono persone che dicono “voglio far l’attore” ma in realtà vogliono lavorare in quell’ambito quindi forse preferirebbero fare gli organizzatori teatrali, i registi, vogliono scrivere, fare cabaret, stand up comedian o attori di cinema.
Mi capita spesso che mi chiedano “ei voglio far l’attore, come devo fare?” Solitamente rispondo in modo standard, con il corso di teatro perché non fa male a nessuno, dovrebbe essere un corso obbligatorio nelle scuole, perché significa imparare a esprimersi, ha molte valenze. Non è detto che fare il corso di teatro significhi diventare attore, ci sono infinite strade, basta capire quella che davvero si vuole seguire.